
di Elena Tempestini
HQ-9B e la dottrina egiziana: un caso di hedging strategico nel cuore del Medio Oriente
L’iniziativa egiziana si colloca in un momento di cambio di prospettiva da parte del governo di Al Sisi: se negli anni scorsi sembrava in qualche modo acquiescente verso le “esigenze” israeliane, oggi l’Egitto inizia a rendere chiaro che qualsiasi sconfinamento verso il suo territorio incontrerà una reazione.
Anche la Turchia si sta attrezzando per contrastare eventuali attacchi da parte di Israele, attacchi che possono venire dalla Siria, dove i turchi stanno cercando di insediarsi collaborando col regime post-Isis di Al-Sharaa, oppure da Cipro Nord: da tempo, e lo abbiamo anche dimostrato, inglesi e israeliani (col probabilissimo sostegno greco) stanno cercando di riunificare con la forza l’isola.
Per questo motivo turchi pachistani e iraniani stanno dando vita a una nuova coalizione militare che in qualche modo ripete lo schema del Patto di Baghdad del 1955: stavolta senza inglesi, che in questo caso rivestiranno il ruolo di nemici, e forse senza iracheni. Perché l’Iraq dal 2003 è territorio conteso tra Occidente, Paesi arabi, e dallo stesso Iran che di fatto lo ha reso suo satellite.
Non a caso i propugnatori della Grande Israele prevedono di scontrarsi con i persiani proprio nei deserti della Mesopotamia.
Nel frattempo un’Italia completamente arravogliata sul fantasma di un’invasione russa che non ci sarà mai continua a ripetere con insistenza quello che Rutte (nomen omen) le impone di dire.
(IFO)
Il recente posizionamento di sistemi missilistici a lungo raggio nella penisola del Sinai costituisce un’evoluzione di rilievo nella postura difensiva egiziana. Tali capacità, con copertura estesa fino a trecento chilometri, permettono al Cairo di controllare uno spazio aereo che si sovrappone, non solo ai confini nazionali ma anche a settori sensibili del Mediterraneo orientale, della Striscia di Gaza e del Mar Rosso. In termini operativi, si tratta di un rafforzamento della “zona d’interdizione” che riduce la possibilità di azioni ostili o incidenti transfrontalieri non desiderati.
L’iniziativa non deve essere letta in chiave di provocazione, bensì come misura preventiva di deterrenza. L’Egitto, infatti, traccia confini chiari circa la propria sovranità e segnala che eventuali operazioni condotte da attori regionali non potranno essere estese automaticamente al proprio territorio. Questa impostazione rientra in una logica classica di “defense by denial”, volta a scoraggiare intrusioni prima che si verifichino.
Sul piano delle alleanze, la scelta di ricorrere a sistemi di fabbricazione cinese riflette una strategia di diversificazione. Pur rimanendo beneficiario degli aiuti militari statunitensi, il Cairo mostra di voler ridurre la dipendenza esclusiva dall’Occidente, inserendo nuovi fornitori all’interno del proprio arsenale. Tale orientamento è coerente con un progressivo multipolarismo nel mercato delle armi e con l’intento egiziano di rafforzare la propria autonomia decisionale. Le esercitazioni con partner asiatici e i programmi di coproduzione rientrano in questa traiettoria, offrendo all’industria locale opportunità tecnologiche e industriali non trascurabili.
L’aspetto più rilevante è di natura geopolitica. In un contesto mediorientale frammentato, l’Egitto riafferma il proprio ruolo di “balancer”: un attore che non cerca il protagonismo conflittuale ma che difende in modo credibile i propri interessi, mantenendo capacità di mediazione. Tale approccio consente al Cairo di rassicurare i vicini arabi e, al contempo, di inviare un messaggio implicito a Israele: la sicurezza egiziana non è negoziabile, e il Sinai non rappresenta uno spazio neutro o sacrificabile.
Dal punto di vista economico-militare, l’accordo con Pechino non è privo di implicazioni interne. La prospettiva di trasferimenti tecnologici e produzioni locali, in una fase di pressione macroeconomica per il Paese, si traduce in potenziale valore aggiunto per la filiera della difesa nazionale. Non si tratta dunque solo di un rafforzamento militare, ma di un investimento che unisce sicurezza, autonomia industriale e stabilità finanziaria.
Quindi, il dispiegamento missilistico egiziano nel Sinai deve essere interpretato come una manovra calibrata di “strategic hedging”: rafforzare la difesa, diversificare i partner e consolidare il proprio ruolo regionale senza oltrepassare la soglia della provocazione. Una mossa che combina prudenza e fermezza, inscrivendosi nella tradizione militare egiziana di mantenere il Sinai sotto stretto controllo come garanzia ultima della propria sovranità nazionale.


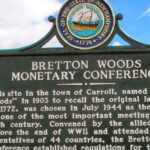



Lascia un commento