Iniziamo un viaggio tra le varie città italiane per analizzare cause e sintomi del declino nazionale cominciato nel 1992. Un declino lento, uno stillicidio che ha visto l’economia italiana scivolare dalle prime posizioni mondiali a una condizione stagnante dalla quale non sembra poter uscire. La trasformazione dell’Italia da Paese industriale e produttivo a Paese della speculazione edilizia e del terziario non è mai stata evidente come in questi anni, soprattutto da quando il 2020 ha dato quella che molti ritengono la spallata finale.
E’ vero, i problemi che affliggono le città italiane sono comuni a tutta Europa e non solo: inflazione, caro affitti, speculazione immobiliare, stipendi bassi: ma nel caso italiano siamo di fronte all’unica nazione europea nella quale le paghe sono calate significativamente rispetto all’inizio degli anni Novanta. Secondo alcune scuole di pensiero questo si deve all’avidità delle imprese, ma bisogna ricordare che a fronte di un risicato stipendio da milleduecento euro il datore di lavoro è costretto a pagarne oltre tremila in tasse e contributi previdenziali che il lavoratore non vedrà mai sotto forma di pensione.
Iniziamo questo viaggio da Bolzano, meta turistica amata in tutta Europa, ma poco conosciuta dagli italiani che pure numerosissimi la frequentano. Molti sono ancora convinti del fatto che il Trentino Alto Adige/Sud Tirol campi a spese del resto d’Italia, quando è vero esattamente il contrario: fino al 2011 la Provincia Autonoma tratteneva sul territorio (e reinvestiva) il novanta per cento delle imposte, dal governo Monti in poi la percentuale si è abbassata al sessanta. E anche questo è un fatto.
Arrivare a Bolzano è un po’ come sbarcare su un altro pianeta: ci si insinua nella valle dell’Adige tra due costoni di montagne assurdamente alti, serpeggiando tra vigneti e paesetti da cartolina. La stazione di Bolzano ha l’aria del monumento decaduto, là dove l’architettura trionfale ospita squallidi bar e sale d’aspetto degne di un pronto soccorso.
L’ambiente nella piazza antistante è quello un po’ di tutte le stazioni europee, pendolari di fretta e soggetti di varia natura in cerca di un portafoglio da sfilare o di un po’ di droga da vendere. Proseguendo verso Via Ferrovia ci si può infilare direttamente in centro e raggiungere Piazza Walther, oppure il Comune Vecchio e quindi la centralissima Via Portici. Ma a sinistra da Via Garibaldi si possono raggiungere i molto più popolari quartieri Don Bosco e Novacella, a destra lungo Via Renon si va ai Piani, zona in bilico tra declino industriale e fantasmi di riqualificazione.
In effetti il tema portante di qualsiasi discorso pubblico a Bolzano è proprio la riqualificazione. Ovvero la spada di Damocle della speculazione edilizia che sta per colpire la zona della stazione e delle vecchie officine ferroviarie, una chimera attorno alla quale si coagulano paure e speranze dall’ormai lontano 2006.
Trecentocinquantamila metri quadri da consegnare ai mercati, un milione e duecentomila metri cubi da costruire per alloggiare centoventi appartamenti, un albergo da centodieci camere e un garage da ottocentocinquanta posti, più il primo supermercato Esselunga della zona.
Quelle che un tempo erano le Ferrovie dello Stato, oggi bisogna dire RFI, non sono estranee a questo progetto, e fantasticano di trasferire la stazione verso le rive dell’Isarco allontanandola da dove è sempre stata dal 1857. L’edificio storico, peraltro opera dell’architetto Mazzoni verrebbe però conservato, forse per alloggiare qualche rivendita di speck e ricordini. Oppure uno degli spazi di co-working che vanno tanto di moda a Bolzano in questi anni dove si chiacchiera di start-up e progetti innovativi.
Sta di fatto che dopo la fine della Bolzano industriale, avvenuta tra gli anni Ottanta e Novanta con la chiusura delle fonderie Falck e di altri importanti stabilimenti, il posto occupato dalle fabbriche oggi deve necessariamente trasformarsi in case, centri commerciali, e alberghi. Dopotutto, cosa si produce più a Bolzano se non i blindati Lince e i biscotti della Loaker? C’è il turismo, certo, in aumento di anno in anno insieme al costo della vita in città. Ma soprattutto, come ovunque, c’è la speculazione edilizia a cui si accompagna la cosiddetta gentrificazione, ovvero il recupero immobiliare di zone un tempo popolari che ha per risultato la cacciata dei vecchi abitanti.
Succede ovunque nel mondo, è vero, ma a Bolzano si scontra con una storia locale molto più complessa di quanto si creda.
Dopo l’occupazione italiana di fine 1918, la città ha subìto una trasformazione economica e sociale molto profonda. Per decenni gli autoctoni di lingua tedesca sono stati considerati come sudditi coloniali da domare in qualche modo, e loro hanno dato vita a vari movimenti di resistenza: soprattutto quando l’uso del tedesco è stato bandito negli uffici pubblici e nelle scuole, così come quando i loro cognomi (insieme alla toponomastica) sono stati sommariamente italianizzati. Nel frattempo, sfruttando anche la posizione strategica, il governo italiano ha proceduto all’industrializzazione della città chiamando sul posto decine di migliaia di lavoratori da tutte le zone del Paese. Tra i sud-tirolesi occupati e gli italiani si sono infilati negli anni Trenta i nazisti, che hanno aperto uffici per convincere i primi a emigrare verso il Reich millenario e i nuovi territori da conquistare, poi nel settembre del 1943, dopo la caduta del regime fascista, quello che conosciamo come Alto Adige per quasi due anni è diventato parte stessa del Reich millenario di cui sopra. Durante l’occupazione tedesca si è assistito a una strana collaborazione tra fascisti e resistenti del Comitato di Liberazione Nazionale per difendere la cosiddetta italianità di Bolzano. Italianità che poi i vari trattati di pace hanno confermato, visto che il vicino passo del Brennero veniva considerato dalla Nato come la porta di ingresso che i sovietici avrebbero percorso nel caso di un’invasione su vasta scala della pianura padana.
I sovietici non sono mai arrivati, in compenso il nuovo regime repubblicano nato dalla resistenza ha subito ribadito divieti e repressione linguistica come nel Ventennio appena trascorso. Anzi, ha addirittura proseguito nella costruzione di alcune opere iniziate anteguerra come l’Intendenza di Finanza: un edificio completato nel 1950 che sul frontone ostentava fino a pochi anni fa un bassorilievo del Duce a cavallo con la dicitura “credere – obbedire-combattere”. Cinque anni dopo la fine della guerra e della caduta del regime fascista stesso. Ma già dagli anni Trenta esiste una Bolzano italiana architettonicamente diversa dal centro storico: ognuna delle due etnie ha la sua città, sulle rive del fiume Talvera si può assistere a uno spettacolo da Disneyland o da Esposizione Internazionale: da un lato le vecchie case con i tetti spioventi e le guglie a cipolla, dall’altro la tipica edilizia monumentale italica del Ventennio che trova il suo apogeo nel Monumento alla Vittoria, il quale ostenta ancora oggi un bel numero di Fasci nella sua decorazione.
Questa immagine racconta bene il modo in cui italiani e sud-tirolesi hanno vissuto dal 1918 a oggi, cioè ognuno per conto suo. Anzi, combattendosi, perché nella Seconda guerra mondiale ognuno ha avuto le sue illusioni riguardo al cacciare l’altro e la convivenza forzata è sfociata più volte in atti di terrorismo e guerriglia. Pochi ricordano che negli anni Sessanta gruppi di resistenti si sono scontrati più volte contro l’esercito italiano sulle montagne intorno alla città mentre vari attentati hanno colpito le istituzioni e l’infrastruttura italiana.
Qualcuno sostiene che questa guerra civile dimenticata sia stata in parte spinta e finanziata dalla Nato per giustificare la massiccia presenza di forze nel territorio, altri vedono dietro alle imprese dei movimenti di liberazione sud-tirolesi la mano dei Servizi della Germania dell’Est e della Cecoslovacchia. Probabilmente sono vere tutte e due le ipotesi, data la posizione cruciale della zona tra Est e Ovest.
Nel 1970 l’uso della lingua tedesca viene finalmente riconosciuto nella vita pubblica, al punto che gli impiegati di lingua italiana sono costretti a certificarne la conoscenza approfondita, così come quelli di lingua tedesca sono costretti a dimostrare la padronanza dell’italiano: è il cosiddetto patentino.
Dal dopoguerra a oggi un solo partito è stato il perno della vita economica della città e non solo: l’SVP, il Sud Tiroler Volks Partei, storicamente allineato al centro-sinistra nazionale, e sempre più simile al Partito Unico di qualche regime autoritario.
Esiste un patto non dichiarato tra italiani e sud-tirolesi riguardo alla gestione dell’economia: ai primi l’amministrazione pubblica, ai secondi turismo e attività produttive basate sul terziario. Negli anni questo patto si è progressivamente annacquato, con tanti germanofoni entrati entusiasticamente nelle istituzioni provinciali, sempre fonti di stipendi elevati e sicuri, ma soprattutto di grandi clientelismi.
Negli anni Settanta e Ottanta le lotte identitarie cessano quasi del tutto e Bolzano si gode un tenore di vita inaudito nel resto d’Italia. Il Trentino Alto Adige non è una Regione come le altre, viene gestito congiuntamente dai consigli provinciali di Trento e Bolzano i quali hanno un’autonomia decisionale che le altre Regioni a statuto speciale non hanno mai voluto mettere davvero in pratica.
Di fatto ci troviamo in una sorta di repubblica indipendente che fino a pochi anni fa era in grado di sostenersi economicamente in maniera del tutto autonoma rispetto a Roma, molto più di quanto sostengano di poter fare Lombardia e Veneto.
Chiunque risiedeva a Bolzano da almeno cinque anni aveva diritto a un contributo per l’acquisto della prima casa di oltre quarantamila euro, giovani coppie e madri single avevano una serie impressionante (per l’Italia) di incentivi e facilitazioni economiche, in generale gli stipendi erano quasi doppi rispetto al resto del Paese. Fino a pochi anni fa.
Poi qualcosa si è rotto.
La prima crisi dovuta al golpe non dichiarato del ’92 e alla dipartita di molte installazioni militari della Nato ha portato alle prime crepe, poi sono arrivati Monti, e soprattutto il 2020.
Nel frattempo buona parte delle industrie ha chiuso portando una crisi non solo economica, ma anche di ruolo per i ceti popolari: se prima ereditare un posto da operaio era la prospettiva naturale per molte famiglie, oggi anche i giovani bolzanini di origine italiana sono costretti a barcamenarsi come i loro coetanei di Milano o Verona. Oggi anche a Bolzano è in aumento il numero di quegli adolescenti che non studiano e non lavorano perché tanto non serve a niente: anzi, spesso e volentieri si uniscono in banda ai nordafricani per rubacchiare e spacciare. E tutto questo mentre le scuole locali mantengono una rigida separazione etnolinguistica.
Su questo sfondo avviene da quasi vent’anni lo psicodramma del cosiddetto areale ferroviario, cioè quella vasta area dietro la stazione dove sorgevano officine e depositi di materiale ferroviario.
Principale attore del sacco di Bolzano, pardon, della riqualificazione, è stato una cordata di imprenditori italiani e tedeschi capeggiata da René Benko, il quale per anni si è dato ad acquisire, spesso con procedure poco chiare, zone di pregio. Non solo l’ex Mercato Generale dei Piani, oggi desertificato, ma anche il bellissimo complesso del Tennis Virgolo, in abbandono dal 2008.
Nel frattempo iniziano i lavori del Waltherpark, una serie di palazzi costruiti dove fino a una decina d’anni fa esisteva la stazione degli autobus, esattamente di fronte a quella stazione che dovrebbe diventare negozio di ricordini.
Poi arriva il 2020.
Nella prima fase della pandemia le Province di Trento e Bolzano si distinguono per un approccio molto meno pesante rispetto al resto del Paese, ma con l’autunno e la istituzione delle famigerate zone a colori (ricordate? bianca, verde, gialla, arancio, rosso, rosso scuro) all’inizio di novembre Bolzano si mette da sola in zona rossa quando perfino il ministro Speranza le attribuirebbe la gialla.
Riguardo a quel periodo circolava la voce che la Provincia avrebbe ricevuto un “contributo” di cinquecento milioni per paralizzare il territorio, contributo che sarebbe arrivato dalla Germania. Con quale scopo? Secondo alcuni quello di uccidere i piccoli negozi e le attività di quartiere per favorire i centri commerciali di prossima realizzazione; secondo altri per castrare economicamente la zona dal tenore di vita più alto in Italia. In effetti le due teorie collimano. Si narra, ma qui bisogna prendere la cosa con le molle, che lo stesso presidente della Provincia Autonoma avrebbe ricevuto un cadeau da sessanta milioni col quale si sarebbe costruito una villa al passo di Resia, dal lato svizzero. Sta di fatto che per la prima volta, e questo è confermato dalla cronaca, un presidente della Provincia Autonoma è stato costretto per diverso tempo a girare con la scorta, fatto inaudito per quelle parti.
Dubitiamo di riuscire a sapere in tempi brevi quanto ci sia di vero in tutto questo, in ogni caso il presidente, landeshauptmann in lingua locale, è stato rieletto a fine 2022. Curiosamente, invece, nelle amministrative del 2025 Bolzano è passata per la prima volta nella sua storia al centro-destra, ma questo ovviamente non cambia di una virgola i progetti speculativi sull’Areale.
Nel 2023 la cordata di speculatori guidata da Benko viene colpita da indagini giudiziarie e lo stesso Benko è costretto a dichiarare l’insolvenza personale. Il gruppo tedesco Schoeller prende in carico la costruzione del Waltherpark e arriva nel 2024 a completarne le prime parti. Naturalmente il Waltherpark ospita già un centro commerciale di lusso.
Ci sono vantaggi per la città? No. La corsa al rialzo dei prezzi di pressoché tutto ha fatto sì che dove dieci anni fa si affittava con sette/ottocento euro al mese oggi si affitta per milleduecento. Dove dieci anni fa una casa si comprava con centocinquantamila euro oggi non ne bastano trecentocinquantamila. Ma le paghe sono sempre quelle del 2015.
Se gli uffici di statistica della Provincia vogliono dipingere un quadro ottimistico della situazione economica (“l’economia bolzanina ha dimostrato una resilienza maggiore rispetto al resto d’Italia”…) basta farsi un giro nel centro, non diciamo nei quartieri popolari Don Bosco o Novacella, per notare il numero impressionante di negozi chiusi e abbandonati. Basta attraversare la Galleria Sernesi, oggi mezza vuota, o altre in città per rendersi conto del declino commerciale. In compenso il Comune in queste settimane vorrebbe “tappare” le vetrine vuote perché secondo gli amministratori sarebbero squallide. Un po’ come si fa da anni in Inghilterra per mascherare case e attività abbandonate, conseguenza della fine di quella Cool Britannia degli anni Ottanta e Novanta che alla fine era solo un mito.
Via Portici, da sempre epicentro del commercio bolzanino, invece somiglia a un mall qualsiasi: stesse catene internazionali, stessi marchi, stessa merce, a discapito di molti negozi locali che spesso vendevano cose caratteristiche. Tutto finito, oggi il modello-Oviesse ha vinto su tutti.
Tutto a misura di turisti nordeuropei o nordamericani per i quali spendere cinquecento euro a notte solo per dormire non è assolutamente un problema. Cosa resterà di Bolzano e della sua storia complicata? Forse il fatto che per la prima volta italiani e germanofoni saranno uniti in una progressiva emarginazione sociale ed economica, là dove non potranno più permettersi di affrontare i costi di una città sempre più da ricchi. Come a Roma, come a Firenze, come a Milano.


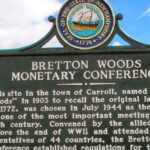



Lascia un commento