In Italia si è parlato della Repubblica del Somaliland solo negli ultimi mesi a seguito di una bizzarra proposta da parte del presidente americano Trump: quella di trasferire gli abitanti superstiti di Gaza nel Corno d’Africa e magari da lì di combattere gli Houthi che dallo Yemen stanno seriamente ostacolando i traffici navali alle porte dello stretto di Bab El Mandeb.
A stretto giro il primo ministro israeliano Netanyahu ha barattato il riconoscimento diplomatico del Somaliland in cambio del permesso di stabilire una base navale, sempre in funzione anti-Houthi, nella città portuale di Berbera.
Due proposte che hanno fatto sollevare non poche sopracciglia in quel di Hargheisa, la capitale somalilandiana, dove pure un riconoscimento diplomatico sarebbe estremamente gradito, ma che sono state giudicate poco realistiche.
Attualmente, nonostante ad Hargheisa siano presenti diverse rappresentanze informali di numerosi Paesi, l’unico Paese ad avere avviato relazioni diplomatiche vere e proprie è Taiwan, nazione a sua volta non riconosciuta da nessuno ma che se la cava comunque benissimo.
A dire il vero ci ha provato la confinante Etiopia due anni fa a stabilire rapporti formali, sempre in cambio della possibilità di stabilire una base navale a Berbera, ma in quel caso è insorta tutta l’Unione Africana col pretesto che non si deve minare l’integrità territoriale degli Stati membri. Già, perché fino al 1991 il Somaliland ha fatto parte della Repubblica Somala, piombata nel caos dopo la cacciata dell’uomo forte Siad Barre.
A dire il vero lo Stato del Somaliland, così si chiamava allora, è stato già indipendente nel 1960, con tanto di seggio alle Nazioni Unite, salvo unirsi alla ex Somalia italiana cinque giorni dopo per dare vita a uno Stato unificato. Ma su questo ritorneremo tra poco.
Culturalmente parlando, pur trovandosi in Africa il Somaliland è a tutti gli effetti un Paese arabo in virtù dei suoi rapporti di lunghissima data con le monarchie del Golfo Persico. Da lì vengono religione (Islam sunnita), organizzazione sociale, in parte anche la lingua. La fusione di tradizioni locali e arabe dà vita al popolo somalo, diffuso tra Somalia, Somaliland, Etiopia, Gibuti.
Crocevia di scambi economici con tutto l’Oceano Indiano da ere immemorabili (la città di Berbera viene perfino nominata in un documento cinese del Tredicesimo secolo), nel 1884 viene occupato dagli inglesi nel corso di quella che è stata chiamata dagli storici la Corsa all’Africa. Proprio negli stessi anni gli inglesi consentono, anzi auspicano, una presenza italiana nella zona al solo scopo di impedire ai francesi di insediarsi nell’area, cosa che questi ultimi finiranno comunque per fare con Gibuti.
Sarà proprio la diffusione del popolo somalo a cavallo di diversi confini tracciati arbitrariamente dalle potenze coloniali a determinare nel corso degli ultimi decenni una serie di conflitti non del tutto risolti.
Probabilmente il Somaliland è la colonia dove gli inglesi hanno investito meno in assoluto, limitadosi a qualche strada tortuosa e ad alcuni edifici amministrativi. Non una ferrovia, non un porto decente, non un’organizzazione urbana degna di tal nome. In compenso gli inglesi hanno bellamente approfittato di quello che a tutt’oggi è il prodotto principale del Paese, il bestiame da allevamento, raccolto soprattutto per alimentare le guarnigioni di Aden e del Sudan.
Per quanto riguarda i rapporti con le popolazioni locali i britannici hanno preferito una serie di piccoli accordi con i potentati locali tra cui la rigida separazione delle zone di residenza e il divieto di fare proselitismo religioso. Questo non ha risparmiato il Somaliland da una serie di insurrezioni politico religiose: la prima, tra il 1899 e il 1920 guidata da Said Mohamed Abdullah Hassan, la seconda nel 1945 con lo sceicco Bashir. Entrambe le rivolte hanno tenuto impegnato il Corpo di Polizia Cammellato, un reparto dell’Esercito britannico appositamente creato nella colonia somalilandiana per mantenere l’ordine e soprattutto riscuotere le tasse. Furono proprio le tasse, a Londra si pensava che la colonia dovesse mantenersi da sola, a dare adito ad altri tumulti negli anni Trenta, che gli inglesi repressero usando l’aviazione, la sola cosa moderna che gli sia riuscito di portare sul posto. L’ordine di bombardare interi villaggi venne niente di meno che da Winston Churchill.
Hargheisa e Berbera vengono occupate dagli italiani tra l’agosto del 1940 e il marzo del ’41. In questi pochi mesi la capitale vede la costruzione del primo ponte sullo uadi, il letto di un torrente che si riempie solo durante la stagione delle piogge, ad opera del Regio Esercito Italiano. Il ponte esiste ancora e per decenni è stato l’unico in tutta la città, ancora oggi viene chiamato il Ponte degli Italiani.
La rivolta del 1945 e il clima politico del dopoguerra suscitano a Londra le prime discussioni sull’opportunità di mantenere la colonia: per controllarla del tutto occorrerebbe realizzare una rete stradale e ferroviaria, insieme a tutta una serie di infrastrutture di contorno, per la quale nessuno ha voglia di investire. “In Somaliland non c’è niente per cui valga la pena combattere” dicono. Eppure decenni di occupazione avrebbero dovuto segnalare agli inglesi la presenza di materie prime e minerali preziosi che a tutt’oggi non sono sfruttati.
Il 26 giugno del 1960 il Somaliland diventa uno Stato indipendente riconosciuto dalla cosiddetta comunità internazionale. Primo ministro è Muhammad Haji Ibrahim Egal, destinato a tornare alla presidenza nel 1993. Nel frattempo, il primo luglio del 1960 lo Stato del Somaliland decide di unirsi alla ex Somalia italiana per dare vita alla Repubblica Somala, di cui farà parte per una trentina d’anni.
Ma già i primi mesi dell’unione rivelano qualche crepa nell’entusiasmo pan-somalo dell’unificazione: un gruppo di ufficiali somalilandiani formati nelle accademie britanniche occupa lo stesso primo luglio del ’60 la stazione radio di Hargheisa per incitare la popolazione a rimanere uno Stato indipendente. In seguito, sempre in ambito militare, diventerà chiaro che nel nuovo regime unitarista somalo le posizioni di vertice andranno quasi sempre a ufficiali addestrati in Italia.
Ma in politica, almeno nei primi anni, non saranno pochi i somalilandiani ad occupare posizioni di preminenza. Fino al 1969.
Parlare di Somalia e Somaliland dopo questa data significa fare i conti con la figura di Siad Barre, un uomo dalle visioni grandiose artefice di un primo periodo di sviluppo per il Paese e poi della sua rovina.
Militare con un passato nelle forze armate coloniali italiane e in seguito allievo della Scuola Marescialli dei Carabinieri a Firenze, al momento dell’indipendenza viene nominato vice-comandante delle forze armate somale. Bisogna dire che in quel momento l’esercito somalo è la forza sociale più attiva e si fa promotore di iniziative culturali arrivando a organizzare perfino concorsi di danza e poesia. Tra gli ufficiali il dibattito politico è acceso, molti credono che l’unico modo per portare modernità e indipendenza economica sia l’instaurazione di un regime socialista, Barre stesso critica il regime moderato di Mogadiscio in un’intervista al quotidiano L’Unità definendo il governo corrotto e inefficiente. Il 15 ottobre del ’69 il presidente Shermarke viene ucciso nella città di Las Anod, sei giorni dopo una giunta militare prende il potere instaurando una repubblica popolare.
Nonostante le nazionalizzazioni e il carattere sovietizzante della nuova repubblica, la nuova Somalia ci tiene a mantenere buoni rapporti con l’Italia, come dimostrato in una serie di interviste concesse a un allora giovanissimo Emilio Fede che si possono vedere su youtube: notevole l’italiano di Siad Barre, senz’altro migliore di quello di certi ministri degli esteri italiani degli ultimi anni, specie di quelli che continuano a mantenere inspiegabilmente incarichi di prestigio con l’Unione Europea.
I primi anni del regime di Barre non sono negativi: vengono aperte scuole professionali, ospedali, accorrono specialisti da tutta Europa, specie quella dell’Est, per curare la formazione dei giovani somali. L’esercito stesso, nel migliore stile socialista di quegli anni, partecipa al raccolto e alla costruzione di canali di irrigazione. Il sostegno economico arriva principalmente dall’Unione Sovietica e dalla Repubblica Democratica Tedesca, oltre ovviamente dall’Italia. Anzi, saranno proprio gli italiani a fornire docenti e programmi di studio alle università somale.
Siad Barre si considera uno dei grandi teorici del socialismo e si fa ritrarre insieme a Marx e Lenin (!).
Questo non impedisce al governo di organizzare occasionali campagne di repressione. All’inizio contro gli esponenti del regime deposto tra cui lo stesso Egal, poi contro nemici veri e presunti.
Secondo alcuni, la decisione nel 1977 di attaccare la regione dell’Ogaden sotto controllo etiope. Sotto il pretesto di conquistare un territorio culturalmente somalo si dice che si nascondesse la necessità di eliminare un gruppo di oppositori tra i ranghi dell’esercito, cosa che effettivamente avvenne.
Le prime fasi della guerra dell’Ogaden vedono l’esercito somalo arrivare a poche decine di chilometri da Addis Abeba. Bisogna considerare che in quel momento l’Etiopia era nel pieno del caos seguito alla rivoluzione socialista che nel 1974 aveva deposto l’impertatore Haile Selassie. Anche quella rivoluzione matura in seno all’esercito, ma degnera presto in una ridda di purghe e massacri. L’attacco somalo e l’avanzata provocano risultati inaspettati. L’Unione Sovietica, dopo avere provato a mediare tra i due regimi, si schiera con il Derg, il Consiglio Rivoluzionario etiope, e taglia ogni sostegno alla Somalia fino ad allora considerata un alleato. Cuba interviene con due divisioni del proprio esercito, inaspettatamente Israele fornisce piloti e tecnici per rimettere in funzione l’aviazione ferma da tre anni. L’esercito somalo viene ricacciato dentro i propri confini, qualcuno considera un regalo il fatto che etiopi sovietici e cubani non tentino la marcia sulla vicina Hargheisa e quindi su Mogadiscio.
Curiosamente Barre ottiene il sostegno di americani e cinesi, ovviamente in chiave anti-sovietica, ma anche dell’Iran, e viene rifornito di armi e consulenti.
Ma questo non basta a fermare il declino della Repubblica Somala. Tensioni tribali, tensioni che il regime socialista ha provato in prima battuta a nascondere, e risentimenti tra i vertici dell’esercito minano la stabilità del regime.
Aumenta la repressione, soprattutto a nord, ovvero nel Somaliland, i cui abitanti vengono ritenuti artefici della sconfitta militare nell’Ogaden. Unità dell’esercito somalo cominciano a fare quello che facevano le truppe coloniali inglesi: razziano villaggi, bombardano, avvelenano i pozzi.
Ad Hargheisa non sono in pochi a pentirsi della decisione di entrare in uno Stato comune con chi ha cominciato a massacrarli.
Inizia un movimento di resistenza schierato su più fronti che ha l’obiettivo di deporre Siad Barre che sfocia in una guerra civile. Nasce il Somali National Movement con l’appoggio sostanziale dell’Etiopia, movimento che sarà tra i fautori della Repubblica del Somaliland.
Gli anni Ottanta vedono lo Stato somalo collassare sia sul piano finanziario che organizzativo. Molti dirigenti locali si improvvisano signori della guerra mentre Mogadiscio cerca un capro espiatorio e lo trova nel Somaliland. Molte sono le teorie su come si sia arrivati a questo. Qualcuno attribuisce l’odio per i somalilandiani, segnatamente verso la tribù maggioritaria degli Isaaq, al fatto che i ribelli al tempo della Rivolta dei Dervisci hanno ucciso il padre e il fratello di Barre, altri semplicemente alla gelosia verso le loro capacità imprenditoriali. In questo contesto è il genero di Barre, Morgan, a elaborare un famoso rapporto nel quale si consiglia la completa eliminazione di questa gente.
Altri attribuiscono l’inasprimento di Barre verso tutto e tutti a un incidente d’auto che ha avuto nel 1986, quando la vettura su cui viaggia finisce contro un autobus. Viene curato in Arabia Saudita e, nonostante all’inizio fosse in pericolo di vita, si riprende nel giro di un mese. Ma non è più lo stesso, dicono. Durerà al potere altri cinque anni. Nel frattempo la Somalia entra nel caos.
Già nel maggio del 1988 le città somalilandiane di Burao e Hargheisa vengono liberate dal Somali National Movement. L’aviazione somala per rappresaglia bombarda e rade al suolo Hargheisa in uno degli episodi più perversi della lotta di liberazione: ancora oggi nel centro di Hargheisa un vecchio Mig somalo viene conservato come monumento per ricordare un avvenimento che oggi è al centro dell’epica nazionale.
Dopo la cacciata di Barre, avvenuta il 26 maggio del ’91, le varie forze politiche che lo hanno combattuto cercano un accordo senza riuscirci. A quel punto entrano in lotta tra loro per una supremazia che non arriverà mai per nessuno.
Se nei primi mesi i somalilandiani avevano sperato di trovare un compromesso onorevole dopo una lotta di liberazione durata oltre dieci anni, diventerà subito chiaro che i vecchi equilibri tutti a favore del Sud sono quelli che l’amministrazione provvisoria di Mogadiscio, comunque destinata a durare poco, intende mantenere.
Tra aprile e maggio ’91 le principali forze politiche somalilandiane si riuniscono nella città di Burao per definire l’assetto del loro Paese. Abdirahman Ahmed Ali Tuur diventa il primo presidente della Repubblica del Somaliland e rimarrà in carica fino al 2003, a succedergli saranno Muhammad Haji Ibrahim Egal, Dahir Riyale Kahin, Ahmed Mohamed Mohamoud, Muse Bihi Abdi . Il presidente attualmente in carica è Abdirahman Mohamed Abdullahi, eletto nel 2024.
Da allora il Somaliland è in pace, se si eccettuano gli scontri occasionali al confine orientale con la regione autonoma del Puntland.
Nel 2001 un referendum popolare ratifica la nuova Costituzione.
Il Somaliland è una repubblica presidenziale in cui presidente e parlamento sono eletti a suffragio universale. Il presidente attuale, Abdirahman Mohamed Abdullahi (Cirro), è stato eletto a dicembre 2024 in una votazione che qualunque osservatore internazionale ha definito tranquilla e trasparente. Del resto in Somaliland funziona una Commissione Elettorale severissima ed efficiente che si occupa del buono svolgimento delle tornate elettorali. Abdi ha sconfitto il predecessore Muse Bihi Abdi, ex generale delle forze armate, il cui operato non ha convinto gli elettori.ha accettato di buon grado la sconfitta, anche se i suoi sostenitori occasionalmente danno vita a qualche dimostrazione animata.
Ma fondamentalmente il Somaliland è e rimane una democrazia funzionante. Nessun candidato viene arrestato o escluso dalla contesa elettorale, diversamente da quanto avviene attualmente nella sedicente democratica Unione Europea.
Il mancato riconoscimento da parte della comunità internazionale, per quanto possa offrire dei vantaggi sul piano fiscale, è comunque sentito come un grosso limite da parte del governo. Occasionalmente inglesi e americani promettono di fare dei passi in questo senso, ma per ora tutto quello che i somalilandiani hanno visto è la visita da parte di qualche senatore repubblicano e un progetto di legge per il ricoonoscimento al Congresso di Washington.
Questo non ha impedito di rifiutare un’offerta da parte della Repubblica Popolare cinese, offerta nella quale veniva imposto il taglio delle relazioni con Taiwan. Naturalmente la posizione italiana verso il Somaliland è quella di continuare a considerarlo parte della vecchia Somalia, pur continuando questa a versare nel caos di una guerra civile di cui non si vede la fine. Nonostante questo, il governo di Mogadiscio non perde occasione per ricordare che, almeno in teoria, il Somaliland è territorio somalo, arrivando perfino a offrire agli americani il porto di Berbera che non controlla dal 1988.
Come abbiamo detto, il tentativo etiope è naufragato nell’opposizione da parte dell’Unione Africana, al punto che, con la mediazione turca, etiopi e somali hanno dovuto trovare un accordo nel 2024. I turchi però mantengono una rappresentanza ufficiosa ad Hargheisa e si incontrano regolarmente col governo somalilandiano anche se il ministro degli Esteri Aden vorrebbe che i turchi prendessero posizione tra Hargheisa e Mogadiscio. Del resto hanno una base navale in Somalia che vorrebbero chiudere a causa delle mancate condizioni di sicurezza: potrebbero essere loro i primi a riconoscere l’indipendenza del Somaliland? Per ora non lo sappiamo.
Nonostante il territorio somalilandiano sia ricco di minerali e pietre preziose, la principale voce di esportazione rimane come nell’Ottocento la carne da macello. Pae che negli anni Novanta l’Eni abbia realizzato una serie di esplorazioni che dimostrerebbe la presenza del petrolio. Si parla anche di uranio, per ora le uniche miniere in funzione sono quelle di oro e argento che qualche imprenditore indiano ha aperto negli ultimi anni.
L’economia si mantiene fondamentalmente sul sostegno da parte degli Emirati Arabi, che così mantengono la loro secolare influenza sul territorio, e sulle rimesse degli emigrati. Emigrati i quali spesso hanno fatto fortuna, soprattutto nei Paesi dell’Anglosfera, e investono soprattutto nell’edilizia. Col risultato che Hargheisa è piena di palazzi e comprensori residenziali di nuova costruzione, ma collegati da una rete stradale ancora primitiva: questo perché lo Stato non ha fondi sufficienti da investire nell’infrastruttura. Allo stesso tempo istruzione e sanità sono gentilmente offerte da organizzazioni private e religiose. Anzi, i religiosi sono particolarmente presenti in una nazione reduce da decenni di laicismo forzato, forse troppo: nonostante il Somaliland possegga una ricchissima tradizione musicale spesso si arriva al paradosso di qualche mullah che manda la polizia a chiudere locali dove si canta e balla. Questo però si accompagna sempre più spesso alla reazione contraria di una gioventù che vorrebbe vivere in maniera più libera, e sotto sotto lo sta già facendo.
Ma se il governo somalilandiano non ha molto da spendere nell’infrastruttura, allo stesso tempo è molto felice di accogliere investimenti esteri in grado di contribuire allo sviluppo economico del Paese. Sta già accadendo nella città di Berbera, dove capitali emiratini hanno rinnovato pochi anni fa il porto commerciale dotandolo di tutti i servizi necessari. Va detto che il porto di Berbera non serve solo alle necessità somalilandiane, ma contribuisce sempre di più all’approvvigionamento commerciale dell’Etiopia, la quale viene taglieggiata da Gibuti essendo costretta a spendere oltre un miliardo di dollari in diritti portuali. Non a caso si parla di un’estensione verso Berbera della ferrovia Addis Abeba-Gibuti, recentemente rinnovata dai cinesi, per velocizzare gli scambi. Nel frattempo i camion fanno la spola tra Berbera e il confine etiope di Wajjale, proprio dove nel 1977 si è combattuto.
Sempre a Berbera è stata istituita recentemente una Zona Franca dove piccole industrie e magazzini si stanno già insediando.
Un altro aspetto poco noto di Berbera è il potenziale turistico: il centro della città conserva testimonianze arabe e ottomane, il mare può rivaleggiare con quello del sovraffollato Kenya. Altre zone di interesse turistico sono rappresentate dalle grotte di Laas Geel con le loro pitture rupestri preistoriche e, si narra, addirittura tombe di giganti ancora da esplorare. In generale il paesaggio e la natura del Somaliland sono ancora attraenti e incontaminati, spesso a poca distanza dalle strade di comunicazione si possono incontrare i classici animali dell’immaginario africano: gazzelle, leoni, facoceri. Per non parlare degli onnipresenti cammelli, alla base dell’alimentazione e anche dei trasporti nelle aree più remote.
A livello di sicurezza il Somaliland ha in Africa pochi rivali: nella capitale e lungo le strade pattuglie armate assicurano l’ordine meglio di tante forze pubbliche di Paesi apparentemente più sviluppati.
Non dubitiamo che questo Paese abbia un futuro di fronte a sé, ma ha bisogno di amici. Di amici che non si comportino da padroni, però.


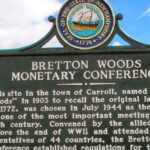



Lascia un commento