“La Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (inglese United Nations Interim Force in Lebanon, arabo قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان; in acronimo UNIFIL arabo يونيفيل) è una forza militare di interposizione dell’ONU, creata il 19 marzo 1978 con le risoluzioni 425 e 426[1] del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.” – Wikipedia
Il primo dispiego di truppe italiane in Libano avviene nel 1982, nel corso dell’intervento multinazionale avviato con l’intenzione di mitigare gli effetti della guerra civile e delle occupazioni siriana e israeliana.
Che cosa abbia risolto la cosiddetta forza di pace è presto detto: i nostri militari si occuparono soprattutto di distribuire aiuti e allestire ospedali da campo per la popolazione civile. Scrive Robert Fisk, giornalista inglese a lungo presente in Libano, che i soldati italiani furono i meglio considerati dalla popolazione locale che li percepiva in un certo qual modo simili a sé. Risulta che molti dei nostri soldati si siano prodigati autonomamente verso i libanesi andando oltre i compiti istituzionali.
L’attentato all’ambasciata americana dell’ottobre ’83, compiuto da Hezbollah e che provoca 241 morti statunitensi e 56 francesi, mette fine pochi mesi dopo alla missione.
Gli italiani torneranno in Libano nel 2000 per vigilare sul rispetto della linea di divisione tracciata dalle Nazioni Unite lungo il confine meridionale libanese per impedire sconfinamenti a Hezbollah o all’esercito israeliano.
Dal 2006 le nostre forze armate mantengono una presenza stabile nella città costiera di Tiro e sempre lungo le zone di attrito meridionali.
Il mandato ufficiale stabilisce, appunto, funzioni di interposizione tra le fazioni combattenti, aiuto umanitario ai civili, e addestramento per l’esercito e le forze di polizia libanesi.
Francamente c’è da chiedersi a cosa serva lo stesso esercito libanese, visto che negli ultimi anni è stato schierato contro la popolazione durante le sommosse del 2020 contro i lockdown che hanno piantato il chiodo nella bara dell’economia già in crisi da anni.
Durante gli attacchi israeliani di queste settimane le truppe libanesi sono state semplicemente consegnate in caserma senza tentare minimamente di onorare il mandato istituzionale di difendere il Paese.
Ma c’è un Paese? Ex possedimento turco fino al 1920, il cosiddetto Paese dei Cedri diventa colonia francese, e così rimane fino al 1943, quando De Gaulle concede l’indipendenza,
I libanesi sono un formidabile miscuglio di tutte le culture mediorientali, tra loro cattolici maroniti, ortodossi, musulmani sciiti ed ebrei. Di fondo si sono sempre considerati più europei che altro, una concezione giustificata dal fatto che la stessa Beirut ha sempre visto una costante presenza europea composta principalmente da commercianti e diplomatici, tra cui molti italiani. Addirittura, nell’Ottocento e in pieno dominio ottomano, Beirut ebbe un governatore fiorentino.
Se queste popolazioni hanno convissuto in qualche modo sotto i turchi, è con la “liberazione” del 1920 che cominciano i guai. I francesi prendono a sostenere la componente cristiana a scapito di quella islamica. E quella islamica si lascia coinvolgere dai movimenti irredentisti arabi che proprio in quegli anni fioriscono un po’ ovunque, anche in seguito al fatto che con la fine dell’impero ottomano l’Islam sunnita perde il suo centro mondiale per dare la stura a tutta una serie di movimenti integralisti particolarmente attivi in Egitto e Palestina.
Con l’indipendenza la costituzione libanese stabilisce che le varie etnie governeranno a turno spartendosi vari settori dell’economia, ma questo modello già negli anni Cinquanta mostra i suoi limiti: nel 1958 scoppia il primo conflitto civile che vede contrapposti i sodali del presidente Chamoun, cristiano filo-occidentale, e i pan-arabisti. La situazione viene risolta da uno sbarco statunitense che mette fine ai combattimeti. Anche nel 1958 l’esercito libanese si limita a chiudersi nelle proprie caserme.
Da lì in poi lo sviluppo finanziario e turistico del Libano placa gli animi. Negli anni Sessanta e Settanta Beirut diventa un rifugio di capitali e di mondanità, la mattina si può andare a sciare sulle montagne intorno a Beirut e il pomeriggio al mare, in tempo per l’aperitivo serale.
Le varie guerre arabo-israeliane producono una forte immigrazione palestinese, i campi dei rifugiati diventano presto una polveriera che finisce per coinvolgere il resto del Paese. Si può discutere all’infinito riguardo all’opportunità di ospitare i profughi palestinesi, ma probabilmente ha ragione chi dice che questo fenomeno non è stato gestito come avrebbe dovuto. I campi diventano sede di organizzazioni militari, in primis l’OLP, e qualche elemento più intraprendente comincia a commerciare armi con tutti quelli che le vogliono comprare: tanto i militanti arabi di sinistra quanto i cristiani di destra cominciano ad ammassare arsenali che poi si riveleranno utili nel 1975 allo scoppio della guerra civile.
La guerra civile libanese può essere descritta come lo scontro di tutte le tendenze presenti nel Paese: da un lato, come abbiamo detto, esiste una destra cristiana filo-occidentale che costituisce una forza militare denominata Falange, dall’altra una serie di movimenti arabisti e islamisti. Ognuno dei due schieramenti ha i suoi sponsor, Israele sostiene la Falange, i Paesi arabi non solo l’OLP ma anche i nuovi partiti Hebollah e Amal.
Esiste una scuola di pensiero secondo la quale tutti i vicini del Libano hanno avuto interesse nel distruggere un Paese ricco e sulla via dello sviluppo, colto e cosmopolita, centro di dinamiche finanziarie internazionali. Gelosia? Oppure il classico banditismo politico universale secondo cui un Paese ricco ma politicamente debole va distrutto?
A turno tutti i Paesi confinanti hanno invaso il Libano proclamando ipocritamente di “non voler restare nemmeno un secondo in più del necessario”.
I siriani manterranno truppe di occupazione fino al 2005, gli israeliani a tutt’oggi vanno e vengono come gli pare.
Cosa fa il governo libanese? Sostanzialmente di occupa di spartire il potere tra le varie famiglie dei notabili bloccando ogni possibile prospettiva di ricostruzione e sviluppo. Se è vero che la fine ufficiale della guerra civile nel 1989, la ricostruzione della capitale, e lo sviluppo turistico hanno consentito una certa prosperità, basarsi su una sola fonte di introiti si rivelerà una scelta micidiale quando la guerra civile in Siria allontanerà i turisti dal 2012. L’economia comincia a collassae e vivacchia di servizi fino al 2019, anno nel quale una profonda crisi finanziaria mette fine ad ogni idea di crescita. Poi arriva il 2020, con quello che sappiamo, e la strana esplosione del magazzino nel porto di Berut, un evento non casuale che molti attribuiscono a un attentato. Comincia a mancare la corrente elettrica, il terziario collassa, i capitali fuggono. Quel poco di ripresa del turismo tra 2022 e 2023 viene eliminato dopo gli eventi del 7 ottobre e la ripresa dei combattimenti.
Viene da chiedersi chi comanda veramente in Libano. Non i cristiani post-falangisti, non Hezbollah, partito sciita regolarmente rappresentato in parlamento e padrone del Sud, e nemmeno gli altri. Probabilemente perché dopo la fine della prima guerra civile e dell’occupazione siriana gli ex-signori della guerra si sono accontentati di fare un po’ quello che volevano senza ridare una struttura al Paese, né un’identità di qualche tipo.
Nelle zone cristiane un certo benessere diffuso consentiva alla popolazione di tenere un tenore di vita paragonabile al nostro, in quelle “gestite” da Hezbollah il cosiddetto Partito di Dio ha realizzato la sua idea di welfare aprendo scuole e ospedali, e distribuendo aiuti alla popolazione. Tutto questo senza che le parti in causa si adoperassero per unire gli sforzi, ognuno ha pensato a sé col risultato che il Libano è incapace di difendersi da qualunque attacco esterno mentre le formazioni militari dei vari schieramenti conducono ognuno la sua guerra, possibilmente tra loro.
L’esercito libanese va più che altro considerato come un carrozzone clientelare che serve a distribuire stipendi e prebende agli elementi delle varie famiglie, ma al massimo combatte contro i civili durante i moti di piazza. Eppure riceve fior di aiuti e addestramento da parte dell’Unione Europea e degli americani. Dall’Italia in particolare ha ricevuto blindati e addestramento negli ultimi anni.
E qui torniamo al contingente italiano.
In questi giorni, al pari delle altre forze Onu, è stato oggetto di attacchi da parte dell’esercito israeliano nuovamente in marcia su Beirut. Per ora non abbiamo avuto feriti, solo qualche mezzo danneggiato, comunica il comandante della missione, generale Del Co. Il nostro ministro degli Esteri Tajani convoca l’ambasciatore israeliano per dirgli che “i nostri soldati non sono militanti di Hezbollah”, intanto le Israeli Defence Forces continuano ad attaccare le basi del contingente multinazionale Unifil esattamente come facevano negli anni Ottanta, quando uccisero diversi militari europei. I governi che allora protestarono sono stati invariabilmente bollati come comunisti e antisemiti.
Il contingente Unifil e i nostri militari non si sono potuti opporre alla ripresa dei combattimenti né hanno risposto al fuoco, che venisse da Hezbollah o dagli israeliani. Se lo scopo era quello di mantenere la pace, è stato ampiamente mancato.
Cosa ci stiamo a fare quindi? Ad addestrare e rifornire un esecito inutile? A prenderci bombe e missili dalle parti in causa senza nemmeno pensare di rispondere al fuoco?
Ministro Tajani, ministro Crosetto: non solo ci dovete una spiegazione, ma ce la dovete prima del rimpatrio di qualche bara con sopra il tricolore.


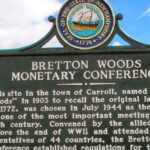



Lascia un commento